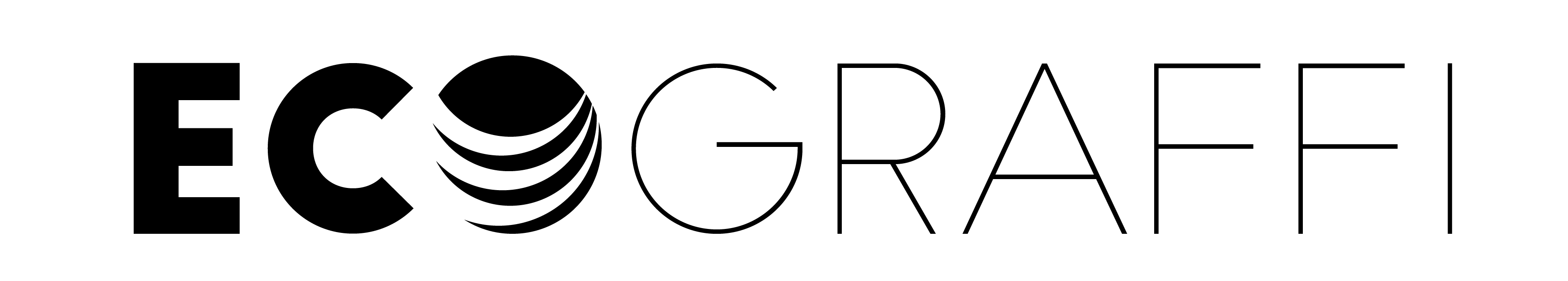Vincenzo Tufano
Nel 1990, per la prima volta, il termine femminicidio compare in un testo dal titolo Femicide: The Politics of woman killing, della criminologa Diane E.H. Russell insieme a Jill Radford. Fu proprio la criminologa a spiegare che tale termine era geneticamente legato alla misoginia, poiché la donna viene uccisa in ambito affettivo/familiare semplicemente “in quanto donna”. Questo, però, non significa che prima di allora il problema non fosse presente.
Quando viene avviata la codificazione del canone tradizionale italiano, nel corso dell’800, dal Ministro della Pubblica Istruzione del Regno d’Italia Francesco de Santis, accade un fatto poco conosciuto: De Santis riprende la Storia della letteratura italiana di Girolamo Tiraboschi, ne depura la strutturazione e vi inserisce la sua visione del mondo, che, purtroppo, non include nessuna autrice.
Ha forse torto Federico Sanguineti quando recentemente ha parlato di un “femminicidio culturale”?[1]
Non è forse questa un’azione volta a silenziare le donne dalla nostra storia letteraria? Abbiamo sì, Laura, Beatrice, Silvia, ma solo perché tali donne servono ai relativi uomini per esprimere meglio la propria capacità scrittoria e immaginativa. Senza Laura, Beatrice e Silvia non avremmo la Vita Nova, mancherebbe buona parte (se non tutto) del viaggio che Dante compie nel mondo ultraterreno, e non avremmo neppure il Canzoniere petrarchesco e A Silvia di Leopardi.
La letteratura è la prima forma d’arte capace di veicolare messaggi in grado di condizionare la vita dei lettori. Le opere che nel corso dei secoli sono state presentate, lette e amate, hanno avuto – tra le altre – la possibilità di parlare di donne, violenze e uccisioni e, contemporaneamente, alcune di loro, hanno tentato di educare all’amore.
Proprio Dante Alighieri (Firenze, 1265 – Ravenna, 1321), padre della lingua italiana e autore della Divina Commedia, ha fatto conoscere a milioni di lettori la storia di due amanti realmente esistiti e che tuttora fanno parte dell’immaginario popolare sentimentale: Paolo e Francesca.
Storicamente la vicenda dei due innamorati è parecchio lacunosa. Ciò che sappiamo è che nel 1275 Guido da Polenta decide di dare la mano di sua figlia Francesca a Giovanni Malatesta (detto Giangiotto da Johannes Zoctus – Giovanni zoppo) il quale lo aveva aiutato a cacciare i Traversari, suoi nemici. Per evitare il possibile rifiuto di Francesca, i signori di Rimini mandarono a Ravenna il fratello di Giangiotto, conosciuto come Paolo il Bello. Francesca, credendo che fosse lui il futuro marito, accetta. Non sapeva che Paolo la sposava per procura, ossia a nome e per conto del fratello storpio. Venuta a conoscenza del tranello e partorita una figlia, la donna si ritrovò a dover vivere una vita disperata.
Negli anni successivi al matrimonio, Paolo faceva spesso visita alla cognata approfittando del lavoro nei suoi possedimenti presso Gradara. Uno dei fratelli, Malatestino dell’Occhio, spiando, s’accorse degli incontri illeciti tra i due.
Un giorno del settembre 1289 Paolo passò da Francesca per una delle sue visite solite, e qualcuno avvisò Giangiotto. Quest’ultimo, anziché andare a Pesaro come di consueto per espletare la sua carica di Podestà, finse di partire, ma rientrò da un passaggio segreto. Mentre i due amanti leggevano della storia di Lancillotto e Ginevra, si diedero un casto bacio. Proprio in quell’istante Giangiotto aprì la porta e li sorprese: accecato dalla gelosia estrasse la spada e li finì entrambi.
Le due terzine più famose del canto e, forse, dell’intera opera (Inferno, 100-105), rappresentano l’amore perfetto al quale tutti gli esseri umani aspirano:
Amor, ch’al cor gentil ratto s’apprende
prese costui de la bella persona
che mi fu tolta; e ’l modo ancor m’offende.
Amor, ch’a nullo amato amar perdona,
mi prese del costui piacer sì forte,
che, come vedi, ancor non m’abbandona.
Tentiamo preliminarmente una parafrasi per avvicinarci più possibile al testo: l’amore, che si lega subito al cuore gentile, fece innamorare costui (Paolo) del bel corpo che mi fu tolto, e la maniera mi fa ancora male. L’amore che non consente a nessuno che sia amato di non ricambiare, mi prese per la bellezza di costui (Paolo) con tale forza che, come puoi vedere, non mi ha mai abbandonata finora.
È l’amore, dunque, che stringe indissolubilmente i due protagonisti, e non una condizione temporanea causata da un fatto terzo, come Francesca cercherà di dire più avanti. Infatti, procedendo (Inferno, 127-138), è la letteratura ad essere accusata da lei di aver causato il precedente; è la voglia di imitare l’amore tra Lancillotto e Ginevra a creare il danno irreversibile. È come se Francesca, nonostante sia già morta, faticasse ad ammettere che la causa della sua uccisione è da ricercarsi in un sentimento nobile che non ha bisogno di essere spiegato e che non può essere condannato:
Noi leggiavamo un giorno per diletto
di Lancialotto come amor lo strinse;
soli eravamo e sanza alcun sospetto.
Per più fiate li occhi ci sospinse
quella lettura, e scolorocci il viso;
ma solo un punto fu quel che ci vinse.
Quando leggemmo il disiato riso
esser basciato da cotanto amante,
questi, che mai da me non fia diviso,
la bocca mi basciò tutto tremante.
Galeotto fu ’l libro e chi lo scrisse:
quel giorno più non vi leggemmo avante».
Dante, comunque, colto da un profondo sentimento di empatia e pietà nei confronti dei due, decide di alleviare la pena. Le due anime non camminano separate, ma proseguono una accanto all’altra, come a voler permettere loro di continuare a vivere quel sentimento oltre la vita carnale, Inferno, 73-75:
I’ cominciai: «Poeta, volontieri
parlerei a quei due che ’nsieme vanno,
e paion sì al vento esser leggeri».
A tale proposito conviene ricordare che nel nostro Paese, l’art.587 del Codice Penale (R.D. 19 ottobre 1930, n.1398), secondo il quale:
Chiunque cagiona la morte del coniuge, della figlia o della sorella, nell’atto in delitto d’onore ne scopre la illegittima relazione carnale e nello stato d’ira determinato dall’offesa recata all’onor suo o della famiglia, è punito con la reclusione da tre a sette anni
è stato abrogato dall’art.1 della L.5 agosto 1981, n.442. Quarant’anni fa. Prima di allora, in buona sostanza, un delitto commesso per difendere il proprio onore o quello della propria famiglia, in uno stato di ira derivante da una relazione carnale illegittima da parte di moglie, figlia, sorella, prevedeva una riduzione della pena. Se un uomo uccideva perché il suo onore era stato macchiato, veniva sommariamente compreso dalla giustizia.
Neppure uno dei massimi rappresentanti del Verismo italiano, Giovanni Verga (Catania, 1840 – Catania 1922), esita a raccontare con minuziosità uno stupro, con conseguente femminicidio, nato dall’idea misogina dell’intima debolezza femminile,[2] nella poco conosciuta novella dal titolo Tentazione![3]
Nel secondo Ottocento le novelle che hanno proposto temi quale la violenza sulle donne, stupri e femminicidi, sono parecchie, ricordiamo almeno quelle di Luigi Capuana (Mineo, 1839 – Catania, 1915) e Federico de Roberto (Napoli, 1861 – Catania, 1927). Non a caso, anche questi ultimi due furono sostenitori convinti della poetica verista.
Nell’opera in oggetto non è presente alcuna condanna morale da parte dell’autore, né reticenze moralistiche o elusioni di particolari scabrosi. Verga si limita a sottolineare un concetto al quale non ci siamo ancora abituati: la violenza non è prerogativa delle menti predisposte al crimine, ma riguarda chiunque. Per lasciar passare questo messaggio è necessario esibire tutti i passaggi dell’accadimento.[4]
I protagonisti sono tre giovani ragazzi i quali, sulla strada del ritorno da una festa a Vaprio, vicino Milano, incontrano nel buio e nel silenzio della notte una giovane contadina. L’autore non accenna alla bellezza fisica o al portamento, e non citerà mai neppure il nome, come se fosse una protagonista spersonalizzata, non solo vittima, ma pure oggetto inanimato. Per il solo fatto di essere donna essa è una tentazione disturbante. A iniziare ad importunare la giovane è Carlino:
- Che gamba, neh! Borbottò Carlino.
- Se va di questo passo a trovar l’innamorato, felice lui!
La misoginia dei tre inizia subito a farsi largo tra le pagine: riferendosi alle gambe della donna, non stanno facendo altro che ridurre e sessualizzare il corpo di lei. Altre espressioni ascrivibili a questa tipologia di espediente sono sparse per la novella: «Perdio! se era bella! Con quegli occhi, e quella bocca, e con questo, e con quest’altro!»
Dopodiché iniziano ad aggrapparsi alla sua gonnella e la ragazza non esita a reagire scompostamente, quasi a volerli intimidire:
- Io non ho paura di voi né di nessuno! Rispose lei.
- Né di me?
- E neppure di me?
- E di tutti e tre insieme?
- E se vi pigliassimo per forza?
I tre giovani assicuratisi che non ci sia nessuno nei paraggi, iniziano a chiederle dei baci, ma, al rifiuto, inizia una zuffa, con la giovane che graffia i tre che cercano di bloccarla e stuprarla.
Verga enfatizza il rifiuto ponendolo tra due virgole, rallentando il ritmo di lettura, e sottolinea che è proprio tale atto di ribellione che scatena il tragico epilogo. Se la donna fosse stata consenziente, non si sarebbe arrivati alla tragedia. Alla fine, la ragazza:
Rimaneva immobile stesa supina sul ciglione del sentiero, col viso in su e gli occhi spalancati e bianchi.
La donna è un oggetto sessualizzato che deve rispondere al desiderio dell’uomo senza rifiuti o cedimenti. Niente può calpestare la virilità maschile. Nel momento in cui tale oggetto non soddisfa le esigenze sessuali del maschio, può essere eliminato, in quanto non più funzionale.
I lettori sono messi di fronte al fatto nudo e crudo. Per far esplodere la tensione e dare alla novella una sfumatura orrorifica, l’autore rincara ulteriormente la dose: i tre assassini, durante la fase di occultamento del cadavere, si rendono conto che il corpo della giovane non entra nella fossa scavata, dunque, le mozzano il capo con un coltello. Sta al lettore intendere le ragioni che hanno spinto i tre ad agire con istinto omicida. Il lettore deve attivarsi affinché l’indagine a proposito di quella violenza possa iniziare e andare avanti, è chi legge che deve sempre razionalizzare e non cadere nella inutile – ma fin troppo abusata – definizione dei «buoni figliuoli» data a posteriori, come a voler dire che mai ci si sarebbe aspettati da tre ragazzini che vivono la loro sessualità con istinti animaleschi un simile fatto.
Mediante un largo salto temporale arriviamo alla scena finale. Ci troviamo in carcere, dove Ambrogio, Carlo e Pigna sono stati condotti per pagare il crimine commesso. Ancora una volta, a sottolineare l’infantilità e il disinteresse dei tre sono i loro stessi comportamenti: non si preoccupano troppo di quello che hanno fatto, ma si incolpano a vicenda e liquidano l’accaduto come uno scherzo finito male:
Come si può arrivare ad avere il sangue nelle mani cominciando dallo scherzare.
Sia Dante che Verga ci mettono al corrente di un fatto: la responsabilità di una violenza non è mai solo di chi la compie, ma riguarda la società intera. È la cultura che va definitivamente cambiata, e perché ciò avvenga c’è bisogno del supporto delle istituzioni. Non basta lo sgomento: servono interventi serissimi.
[1] Sanguineti, 2022.
[2] Mi sembra giusto ricordare che è proprio dalla presunta debolezza femminile che si è sviluppata la perifrasi accusatoria: “sesso debole” o “gentil sesso” per definire le donne.
[3] Per un’indagine più esauriente si veda: Lo Castro, 2012.
[4] Ibid. pg.21.